|
 Il
Risorgimento, fin dalle sue prime fasi filo-francesi del
1796-1799, vide pienamente coinvolta la città di Gubbio, sia come
comunità, sia attraverso alcuni dei suoi cittadini più
rappresentativi. Tante le figure da studiare e da approfondire:
ecclesiastici, politici, professionisti, artisti, tutti cittadini di
un piccolo centro che, posto a mezza strada tra le focose legazioni emiliano-romagnole e le statiche province romane, si trovò a subire
il passaggio della storia in modo non certo indifferente.
Il
Risorgimento, fin dalle sue prime fasi filo-francesi del
1796-1799, vide pienamente coinvolta la città di Gubbio, sia come
comunità, sia attraverso alcuni dei suoi cittadini più
rappresentativi. Tante le figure da studiare e da approfondire:
ecclesiastici, politici, professionisti, artisti, tutti cittadini di
un piccolo centro che, posto a mezza strada tra le focose legazioni emiliano-romagnole e le statiche province romane, si trovò a subire
il passaggio della storia in modo non certo indifferente.
Prima di iniziare questa beve descrizione dei fatti più importanti
che hanno caratterizzato il
Risorgimento a Gubbio
vorrei che sia fatta mente locale su una circostanza che da secoli
ha caratterizzato lo Stato della Chiesa e, quindi, anche Gubbio:
qui il capo dello stato e il capo della religione erano la medesima
persona.
Da questa ovvia considerazione discende gran parte della storia
politica, economica, sociale e culturale delle nostre regioni.
La commistione tra stato civile e stato religioso era continua e
inestricabile. Solo pochi esempi: i privilegi degli ecclesiastici,
la mano morta, il diritto del foro ecclesiastico, i diversi
tribunali e il diverso linguaggio usato negli stessi, la mancanza di
codici legislativi unici, l’avocazione dei processi, il controllo
della scuola e di tutti gli enti caritativi e di assistenza –
ospedale compreso – le modalità di elezione dei consigli comunali
fortemente controllati dall’apparato ecclesiastico ... tutto questo
vigeva qui, da noi.
Questo sistema che aveva funzionato benissimo per secoli e che, bisogna
dirlo, ha garantito lo sviluppo di molti aspetti della nostra
cultura, entrò in crisi alla metà del XVIII secolo.
 Alla fine del Settecento (1796), a seguito della
prima campagna d’Italia di
Napoleone, giunsero dal nord delle strane
persone, con strane idee. Si trattava di gente che aveva tagliato la
testa al loro re e pure alla regina, aveva ammazzato migliaia di
nobili, preti e frati; aveva distrutto un mucchio di chiese; sulla
punta delle loro baionette portavano strani concetti:
libertà, uguaglianza,
fraternità e una cosa chiamata
“Diritti dell’Uomo e del Cittadino”.
Alla fine del Settecento (1796), a seguito della
prima campagna d’Italia di
Napoleone, giunsero dal nord delle strane
persone, con strane idee. Si trattava di gente che aveva tagliato la
testa al loro re e pure alla regina, aveva ammazzato migliaia di
nobili, preti e frati; aveva distrutto un mucchio di chiese; sulla
punta delle loro baionette portavano strani concetti:
libertà, uguaglianza,
fraternità e una cosa chiamata
“Diritti dell’Uomo e del Cittadino”.
Avevano la pretesa di voler mettere la ragione al posto
di Dio; si erano messi in testa di capovolgere un principio più che
millenario secondo cui la sovranità appartiene a chi la riceve da
Dio, cioè al monarca che esercita il suo potere assoluto; loro,
invece, andavano dicendo che il potere è del popolo ed è dal popolo
che proviene; volevano che ogni cittadino – e non suddito –
concorresse alla difesa della "patria": entità misteriosa che da noi
iniziava e finiva alle mura che circondavano le città; non volevano
che si ricorresse ad un esercito mercenario; avevano un tribunale
unico per tutti, una legge unica per tutti; niente privilegi, niente
inquisizione, niente discriminazione religiosa; niente decime;
dicevano che bisognava sequestrare tutti i beni della Chiesa, farci
pagare le tasse, abolire il fedecommesso, la primogenitura, la
validità dei testamenti autenticati solo dagli ecclesiastici;
effettivamente ne volevano un po’ troppe!
Ad ogni buon conto, a seguito della campagna
d'Italia, il 7 febbraio 1797 l’amministrazione centrale della
Legazione di Urbino e Pesaro comunicò il “Nuovo Ordine di Cose”
regolato da Napoleone stesso con apposite norme. Gubbio fu
“invitata” ad aderire alla
Repubblica Cispadana. Cinque
cittadini furono incaricati di giurare obbedienza alla Repubblica e
nei nuovi ordinamenti che i francesi diedero alla nostra provincia e
alla nostra città – credo che oramai sia noto a tutti che Gubbio
fece parte della Provincia (Delegazione) di Urbino e Pesaro fino al 1860 –
gli eugubini furono subito in primo piano.

Ricordo, tanto per fare un paio di esempi, Ubaldo Galeotti, nominato
dal giovane Napoleone commissario provinciale, e Giacinto Tei,
presidente della commissione amministrativa eugubina.
Gubbio non fu esente dal
fenomeno delle insorgenze. La massa rurale,
strettamente controllata dalla Chiesa e forse anche per convinzione
secolare cercò di ribellarsi al nuovo stato di cose,
ma si trattò di un fuoco di paglia.
Figura assai interessante di questo periodo è mons. Ottavio
Angelelli, un dei pochi vescovi che sembra aver appoggiato la
politica napoleonica.
Gubbio, dopo varie vicende, nell'agosto 1800, ritornò a far
parte dello
Stato della Chiesa.
 Infine, tra il 1808 e il 1814
Gubbio entra a far parte del
Regno d’Italia.
Infine, tra il 1808 e il 1814
Gubbio entra a far parte del
Regno d’Italia.
Tutto lo stivale, in mano a Napoleone, è diviso in soli tre stati.
Quelle norme che richiamavo sopra furono tutte applicate e non senza
problemi. La leva obbligatoria, mai digerita dai contadini, cioè
dagli abitanti del contado, creò molti problemi.
Il
Congresso di Vienna sancì il ripristino quasi in fotocopia della
situazione italiana al periodo antecedente al 1796 e riconobbe
all’Austria il ruolo egemonico negli affari italiani.
La bontà e l’efficacia di alcune delle riforme amministrative
introdotte dai francesi è testimoniata dal fatto che alcune di esse
furono mantenute dal
cardinale Consalvi al momento del ristabilimento
del potere pontificio.
La politica, però, tornò ad essere quella di prima.
Il desiderio di partecipare alla cosa pubblica senza essere
aristocratico o possidente diventò spinta insopprimibile. Vedere
ristabilite tutte le vecchie regole spingerà i pochi giacobini
locali a tenere accesa la fiamma della ribellione. Nascono le
società segrete.
Gubbio conosce il fenomeno delle
vendite carbonare, qui operanti
soprattutto per divulgare tra la gioventù massime patriottiche e
anticlericali; anticlericali, non antireligiose.
La prima società, denominata i “Figli di Bruto” nacque nel
1824 a cura di “uno straniero”. Esponenti di spicco furono
Giuseppe Barbi e Damiano Tondi. Poco tempo dopo furono
fondate altre due organizzazioni segrete: i “Figli della
Speranza” e la “Società dei Buoni Amici”, quest’ultima in
opposizione alla società filopapale dei “Compari”. Contro queste
sette operò, anche su incarico del vescovo Vincenzo Massi, Giuseppe
Lucarelli, ingegnere e spia pontificia: un vero personaggio da
romanzo.
Tra i più strenui nemici della Carboneria italiana ricordo
Agostino Rivarola – cardinal “protettore” di Gubbio – che operò soprattutto
nelle Romagne. Le tre sette eugubine, per contrasti interni,
furono scoperte nel 1826. L’anno dopo verranno emesse le
condanne. Ma alcuni carbonari se ne erano già andati in esilio: chi
in Toscana, chi in Corsica, chi a Malta. Proprio a Malta finì
Giuseppe Barbi e lì, tra carbonari esiliati e spie di ogni regime,
finì i suoi giorni, pare avvelenato da una maga.
La nomina di
Papa Gregorio XVI, però, azzerò tutte le novità introdotte
da Consalvi e fece ripiombare lo Stato della Chiesa ai tempi
precedenti la Rivoluzione Francese; ma si illudevano.
Grande, importante e quasi del tutto inesplorata è la storia del
moti del 1831 a Gubbio. Eppure ci sarebbe molto da dire, a
cominciare dal ruolo svolto da Girolamo Beni e da
Francesco Ranghiasci, il quale Ranghiasci, tra l’altro, si recò
a Bologna all’assemblea delle Provincie Italiane Unite per votare
l’abolizione del potere temporale del Papa.
 Fu proprio in quel periodo, ed esattamente il 27 febbraio 1831, che
a Gubbio tornò a sventolare il tricolore.
Fu proprio in quel periodo, ed esattamente il 27 febbraio 1831, che
a Gubbio tornò a sventolare il tricolore.
Fu donato dalla signora Ranghiasci al contingente volontario della Guardia Nazionale e
portato per la città “con somma esultanza”.
La signora Ranghiasci non è altri che Matilde Hobhouse, un
personaggio – l’ennesimo – tutto da riscoprire e che sicuramente non
fu estraneo alla conversione politica dell’illustre marito il quale
però, dopo il 1831, tornò devoto e umile tra le braccia della Chiesa
e non se ne scostò più fino alla fine. Stesso discorso per il conte
Beni che diventò, addirittura, consultore fiscale del Papa.
Calato il sipario sulle sette carbonare ecco affacciarsi
all’orizzonte colui che per quaranta anni incarnerà lo spirito
repubblicano per eccellenza: Giuseppe Mazzini. La
Giovine Italia
fece subito i suoi adepti, anche a Gubbio. Anzi, secondo quanto
ho trovato scritto poche settimane fa, pare che il primo
responsabile eugubino della nuova organizzazione patriottica sia
stato Giuseppe Lucarelli, la spia di cui vi dicevo poco fa.
Gubbio, dopo i moti del ’31, è in continua fibrillazione tanto che
al tempo del cardinale Albani, uno che aveva stroncato anche i
romagnoli, gli eugubini furono definiti popolo inquieto.
Ma è difficile muoversi in un clima reazionario, dove il vescovo
Massi si impegnò molto per tenere a freno i pochi liberali locali.
Due nomi su tutti: il conte Porcello di Carbonana e ancora
Damiano Tondi. Furono loro i padri di quella che sarebbe stata
la nuova generazione patriottica e cospirativa eugubina, quella
degli Agostinucci, dei Leonardi, di Alessandro Domeniconi e di
Angelico Fabbri.
Sono questi gli anni della crisi delle grandi famiglie nobili, crisi
sociale ed economica.
Le ricerche svolte in questi anni mi hanno posto sotto gli occhi i
numerosi drammi familiari che investirono la vecchia aristocrazia
eugubina, l’unica che per censo era stata in grado di generare i
primi esponenti del Risorgimento eugubino. Non era ancora giunto il
momento dei professionisti, né, tanto meno, quello degli artigiani,
cioè di coloro che costituivano i cosiddetti secondo e terzo ceto.
Molte famiglie si spaccarono per avere al loro interno fratelli,
cugini o rami di comune ascendenza ugualmente divisi tra la fedeltà
al legittimo sovrano e la scelta più radicale di democrazia e
benessere diffuso, insomma tra il modello vecchio e assolutista e i
nuovi principi rappresentati allora dalla Francia e
dall’Inghilterra. Cito alcune di queste famiglie: Barbi, conti
Benamati, conti Beni, marchesi Biscaccianti della Fonte – o Fonti –
conti di Carbonana, Elisei, conti Fabiani, conti Marioni, Tondi.
Il
vaso di pandora fu scoperto – inavvertitamente? – proprio dal
monarca del tempo, il
Papa Pio IX. Nei primi due anni del suo pontificato,
1846-1847, Papa Mastai introdusse una serie di riforme che hanno
veramente dell’incredibile, almeno se rapportate al periodo
politicamente nero da cui veniva lo Stato della Chiesa, una stato la
cui intera produzione industriale era inferiore a quella di una
media città inglese. A Gubbio la metà del territorio era in mano
della Chiesa e quattro delle prime otto famiglie possidenti erano
forestiere.
Amnistia, attenuazione della censura, concessione dello Statuto,
attivazione della Guardia Civica. Tutto sembrava avviato verso una
maggiore libertà.
Ma la lotta era tra chi voleva troppo e chi non voleva concedere
nulla.
Nell’agosto 1847 fu arrestato Nazareno Agostinucci. La colpa:
aver organizzato una cena patriottica con esposizione del tricolore.
Nella notte i gendarmi circondarono la sua casa, fecero irruzione e
trovarono l’Agostinucci nascosto in una intercapedine segreta.
Molte informazioni su questo personaggio – come sulla spia Lucarelli
– sono conservate presso l’Archivio Segreto Vaticano.
Anzi, proprio grazie alla collaborazione del dott. Pierpaolo
Piergentili – che lavora in quell’archivio – stanno emergendo
notizie interessantissime sul Risorgimento eugubino che spero, prima
o poi, di riferire in modo adeguato.
Per il momento sono stato autorizzato a riferire che la bandiera
italiana esposta dall’Agostinucci nel 1847 esiste ancora ed è stata
rintracciata in uno dei fondi archivistici dell’Archivio Segreto
Vaticano.
Torniamo al Risorgimento a Gubbio ed arriviamo al
1848.
Il famoso ’48 esplose in tutta Europa con una forza dirompente.
Non era più il tempo delle riunioni carbonare, ebbero fine i tentativi
di insurrezione destinati a fallire prima ancora di cominciare. Ora
scendono in campo interi eserciti.
I nodi politici da scogliere, però, divennero inestricabili. Molti
esponenti della cultura pensarono ad una confederazione di stati
italiani sotto la guida del Papa. E’ il
neoguelfismo che, perlomeno,
garantì un’ampia e relativamente libera diffusione del dibattito
politico.
Ed è proprio all’interno della Guardia Civica, cioè dell’organo
militare locale autorizzato ed approvato, quindi operativo alla luce
del sole, che si svolse il primo vero e proprio processo aggregante
dei patrioti locali. La propaganda interna fu molto forte perché
Guardia Civica significava armi. Gli ufficiali nominati dal Papa, il
marchese Ranghiasci e il conte Carlo Della Porta, rinunciarono
all’incarico. I Fabiani Massarelli furono i protagonisti di questa
nuova situazione. Appoggiarono gli esponenti più liberali e decisi
nella loro azione di penetrazione. All’interno della Guardia Civica
si forgiò gran parte dell’apparato patriottico eugubino. C’erano
tutti!
Nella primavera del 1848 anche i volontari di Gubbio partirono per i
confini dello stato. E’ la grande illusione. Il 29 aprile Pio IX
calerà il velo: niente guerra all’Austria, niente unità d’Italia,
neanche quella immaginata dai neoguelfi.
Questa presa di posizione
gli costerà cara perché sarà alla base di quella esperienza
straordinaria, seppur brevissima, che fu la
Repubblica Romana del
’49 a cui anche Gubbio diede il suo rispettabile contributo. Cito il
conte Ubaldo Marioni che, dopo essere stato eletto a suffragio
universale all’Assemblea Costituente romana, fu spedito da Mazzini a
Londra come ambasciatore della Repubblica presso la regina Vittoria.
Che dire poi dei giovanissimi Bruni e Tinti che seguirono Garibaldi
fino a Cesenatico?
Ma accanto al discorso militare non si può certo dimenticare quello
delle idee, quello della situazione economica e sociale in cui
versavano gli eugubini.
I tempi stavano cambiando rapidamente e
l’elemento cittadino era sempre più propenso ad appoggiare il moto
rivoluzionario. Erano pochi, è vero, ma non si è mai vista una
rivoluzione fatta da tutto un popolo. Sono sempre in pochi quelli
che agiscono.
Cosa si pretendeva poi dalla campagna i cui abitanti erano poco meno
di servi della gleba? E non certo per colpa loro.
Cosa si pretendeva dalle centinaia di mendicanti che vivevano delle
elemosine delle istituzioni clericali?
Cosa si poteva chiedere ai tanti artigiani che dovevano la loro
sopravvivenza al lavoro loro affidato dai conventi e dai monasteri?
Cosa dovevano fare gli organi politici locali quando per l’elezione
del Consiglio Comunale avevano diritto di voto neanche 200 persone,
compresi una quindicina di sacerdoti e una ventina di monasteri,
conventi e enti ecclesiastici di vario genere?
Cosa si poteva fare quando si finiva ai ferri per aver sventolato
una bandiera o ti denunciavano se andavi a fare un bicchierino la
domenica mattina mentre si diceva la messa?
Come si poteva contrastare chi aveva il diritto di controllarti non
solo il corpo ma anche l’anima?
Cosa si poteva fare, in quei tempi, quando ogni azione politica
contro lo Stato sovrano era bloccata dalla minaccia della scomunica?
Dobbiamo quindi essere grati a quei pochi eugubini che pur tra mille
difficoltà e rischiando in continuazione la pelle tennero viva la
fiamma della speranza, senza piegarsi alle bastonature degli
austriaci o ai pesanti rimproveri dei vescovi Pecci e Sannibale che, in
fondo, non facevano che difendere ciò in cui credevano.
Ma pure i patrioti – anche se pochi – credevano!
La fine della
Repubblica Romana coincise con l’affermazione di nuove
idee e nuovi progetti di unità nazionale.
Apparve chiaro come il
Piemonte – che al contrario di tutti gli
altri aveva mantenuto la Costituzione anche dopo l’amarissima
sconfitta subita a Novara – fosse oramai l’unico stato in grado di
guidare la riscossa nazionale.
Furono in molti ad abbandonare le idee di Mazzini e a mettersi sotto
l’ala protettrice di
Casa Savoia.
D’altra parte la scelta di
Garibaldi, già idolatrato delle masse,
aveva aperto la strada a molti altri. Molti, ma non tutti.
Le forze in campo – e parlo di forza militare non solo di quella
politica – erano di tale entità che neanche uno stato relativamente
potente come era il Piemonte poteva battere l’Austria. Ecco il
motivo dell’alleanza di Torino con la Francia di Napoleone III (Accordi
di Plombières). Ancora un passo avanti verso altre speranze, verso altrettante
delusioni. E mi riferisco al
trattato di Villafranca che mise
anzitempo fine alla pur vittoriosa
II guerra d’indipendenza.
E’ venuto il momento di parlare di
Angelico Fabbri: ma come si fa?
Impossibile solo provare a sintetizzare il suo vulcanico operato.
Dirò soltanto che nell’estate del 1859, quando insorsero le
provincie della parte settentrionale dello Sato Pontificio, molte
città della Delegazione di Urbino e Pesaro si ribellarono. Solo
Pesaro e Gubbio rimasero ferme: Pesaro perché lì il delegato Bellà
aveva radunato tutte le forze militari della provincia; Gubbio
perché il Ranghiasci – secondo quanto racconta Fabbri – fu autore di
un bel voltafaccia. Il marchese fu talmente bravo che Pio IX, dietro
segnalazione del delegato mons. Bellà, lo premiò con l’Ordine
cavalleresco Piano e lui – Ranghiasci – fece conferire dal Consiglio
Comunale la cittadinanza eugubina a detto mons. Bellà!
L’anno dopo, però, la campana suonò anche per lo Stato Pontificio.
Una volta avuto il permesso da Napoleone III di impedire a Garibaldi
di raggiungere Roma, i Piemontesi entrarono nello Stato Pontificio.
Il 12 settembre 1860 Nazareno Agostinucci fu liberato dal carcere
pesarese dove era stato rinchiuso dalla fine di luglio. Il regio
commissario provinciale Tanari diede proprio all’Agostinucci
l’incarico di promuovere a Gubbio la formazione degli organi di
governo provvisori. Il
14 settembre mattina gli ultimi ausiliari
pontifici partirono per Ancona, non sapendo che di lì a pochi giorni
avrebbero concluso la loro missione a
Castelfidardo.
Proclamata la
giunta ed esposto il tricolore, gli eugubini rimasero in attesa
delle truppe piemontesi che a due ore di notte giunsero dalla strada
del Bottaccione.
Il tempo di stampare un manifesto celebrativo, e anche i soldati di
Vittorio Emanuele – dopo aver vendemmiato anzitempo nel podere della
Peschiera – si avviarono verso le Marche.
Nell’ospedale di Gubbio rimasero i malati dei due eserciti,
pontificio e piemontese.
Il plebiscito eugubino, come quello di molte altre città, si svolse
senza problemi. I circa 3.900 votanti furono tutti favorevoli
all’annessione.
Certo molti di loro non sarebbero stati contenti di
quanto la Commissione Municipale provvisoria stava tramando, cioè il
passaggio di Gubbio dalle Marche all’Umbria. L’insoddisfazione
cittadina scoppio però alla fine di dicembre.
La situazione locale, però, non migliorò subito.
Nonostante l’impegno del prefetto Filippo Gualterio che si espose in
prima persona – assieme a Fabbri – per garantire un prestito a
Gubbio. Il marchese Luigi Barbi, consigliere provinciale, si trovò
in grande imbarazzo quando cercò di mediare tra la commissione
locale – che si era dimessa in massa – e il prefetto dal pugno di
ferro. La gravissima crisi causata dalla demaniazione delle
Corporazioni religiose peggiorò ulteriormente le cose. Il Comune
riuscì ad avere – grazie ad abili manovre politiche – solo l’ex
Convento di S. Pietro dove dal febbraio 1861 trasferì la residenza
municipale.
Anche i rapporti con la Curia vescovile si fecero molto tesi, tanto
che due sacerdoti diocesani finirono in prigione: uno per aver
predicato dall’altare contro il nuovo ordine delle cose, l’altro per
essere stato trovato in possesso di armi.
 Il 1° aprile 1861 Vittorio Emanuele II nominò il marchese Luigi
Barbi – già gonfaloniere sotto lo Stato Pontificio, già
consigliere provinciale – primo sindaco di Gubbio.
Il 1° aprile 1861 Vittorio Emanuele II nominò il marchese Luigi
Barbi – già gonfaloniere sotto lo Stato Pontificio, già
consigliere provinciale – primo sindaco di Gubbio.
La scelta
premiava il moderatismo del marchese il quale, però, si trovò in
breve tempo in gravi difficoltà con l’ambiente più radicale
cittadino, quello che non gradiva elementi della vecchia guardia
alla guida della città. Per questo, nell’autunno 1861, Barbi fu
costretto a dare le dimissioni e la città, per vent’anni – se
escludiamo la parentesi del marchese Toschi Mosca – fu guidata da
soli tre sindaci, tre protagonisti molto attivi del Risorgimento
locale: Emilio Benamati, Alessandro Domeniconi e
Angelico Fabbri,
quest’ultimo da considerare indubbiamente come l’ultima punta di
diamante della recente storia eugubina.
|
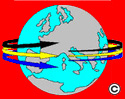




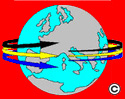




 ibro
(104 pagine) è stato riprodotto e può essere
scaricato integralmente qui.
ibro
(104 pagine) è stato riprodotto e può essere
scaricato integralmente qui.
 Agenda
Agenda