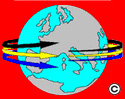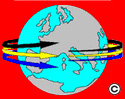|
Il 22 giugno 2014 sono passati 70
anni dall’eccidio, da quella tragica mattina in cui quaranta eugubini morirono
sotto i colpi dell’esercito nazista.
I nomi dei 40, la
loro età:
Allegrucci
Giuseppe, anni 34
Baldelli Carlo, anni 34
Baldoni Virgilio, anni 38
Bartolini Sante, anni 55
Battaglini Enea, anni 20
Bedini Ferdinando, anni 39
Bedini Francesco, anni 50
Bellucci Ubaldo, anni 34
Cacciamani Cesare, anni 52
Cacciamani Enrico, anni 50
Cacciamani Giuseppe, anni 19
Farabi Gino, anni 39
Felizianetti Alberto, anni 23
Gaggioli Francesco, anni 17
Ghigi Miranda, anni 30
Ghigi Zelinda, anni 61
Lisarelli Alessandro, anni 23
Marchegiani Raffaele, anni 57
Mariotti Ubaldo, anni 18
Migliarini Innocenzo, anni 40 |
Minelli
Guerrino, anni 27
Minelli Luigi, anni 42
Moretti Franco, anni 21
Moretti Luigi, anni 22
Pannacci Gustavo, anni 36
Paoletti Marino, anni 30
Piccotti Antilio, anni 41
Pierotti Francesco, anni 40
Profili Guido, anni 54
Rampini Raffaele, anni 43
Rogari Nazzareno, anni 50
Romanelli Gastone, anni 17
Roncigli Vittorio, anni 38
Roselli Luciano, anni 23
Rossi Domenico, anni 41
Rossi Francesco, anni 49
Scarabotta Enrico, anni 36
Sollevanti Giacomo,anni 18
Tomarelli Luigi, anni 61
Zizolfi Giovanni, anni 23
|
 |
Riportiamo in sintesi la
storia attraverso la
ricostruzione della storia fatta dal Prof. Giancarlo Pellegrini:
«All’alba di giovedì 22 giugno 1944, a Gubbio, in una città desolatamente
deserta perché terrorizzata dal coprifuoco e dai rastrellamenti dei giorni
precedenti, 40 cittadini innocenti, tra cui due donne, venivano trucidati per
rappresaglia dall’esercito tedesco, poiché due giorni prima, nel pomeriggio del
20 giugno, in un bar del centro – il caffè Nafissi o "de la Caterina" – era
stato ucciso un tenente medico e gravemente ferito un sottotenente da una
pattuglia Gap, con una operazione eseguita da detta pattuglia fuori degli ordini
ricevuti.
Dopo la liberazione di Roma da parte degli Alleati (4 giugno 1944),
l’esercito tedesco si stava ritirando verso il nord, verso la linea Gotica.
Si era nella fase di passaggio del fronte e in quei giorni a Gubbio sembrava che
l’esercito tedesco avesse pressoché concluso l’arretramento delle truppe oltre i
confini di questo territorio comunale.
Il movimento partigiano, operante nella zona, aveva coltivato il
progetto di voler realizzare la liberazione della città prima dell’arrivo degli
Alleati, che il 13 giugno avevano liberato Terni, il 16 giugno Foligno ed il 20
giugno Perugia.
Nel pomeriggio del 20 giugno, in un clima euforico e confuso,
nell’illusione che fosse possibile liberare la città dall’esercito tedesco,
mentre un gruppo di partigiani – con i loro capi a cavallo – scendeva verso la
città dagli stradoni del monte Ingino, una pattuglia Gap – che aveva ricevuto
l’ordine di recarsi in località Mocaiana dove due o tre soldati tedeschi stavano
facendo azione di saccheggio ed incutevano terrore alla popolazione – iniziò
invece in città il pedinamento dei due ufficiali tedeschi, affrontandoli nel bar
con l’esito sopra indicato: l’uccisione di uno (Kurt Staudacher) e il ferimento
dell’altro (Hermann Pfeil).
Mentre i patrioti scappavano verso il monte, l’ufficiale ferito
riuscì a farsi strada con la pistola in pugno e a raggiungere il comando
tedesco.
La reazione fu immediata: il battaglione tedesco presente nella
zona subito piazzò cannoni, mitragliatrici, iniziando dalla piazza del Mercato
sia un’intensa sparatoria verso il monte e verso diversi palazzi cittadini, sia
il rastrellamento, prendendo in ostaggio gli uomini che incontravano o che
trovavano nelle abitazioni.
Verso la sera del 20 giugno, sembrò che tale azione di rappresaglia
fosse sospesa, dopo che il vescovo mons. Beniamino Ubaldi, portatosi presso il
comando tedesco situato presso l’Albergo S. Marco, aveva cercato pietosamente di
far ricadere su elementi slavi la responsabilità dell’uccisione del tenente
medico, ricevendo da quel comandante tedesco l’assicurazione che venivano
sospesi i rastrellamenti e l’azione conseguente, purché non si fossero
verificati altri incidenti.
Non fu così. Qualche ora dopo la situazione precipitò. Nella notte
furono ripresi i rastrellamenti. Furono presi uomini e donne, giovani e meno
giovani, alcuni rilasciati dopo interrogatori sommari, altri trattenuti.
Inutile risultò, nella mattina del 21 giugno, un secondo intervento
presso il nuovo comandante tedesco da parte dello stesso vescovo Ubaldi, il
quale, essendosi reso conto della tragedia che stava per abbattersi sulla
popolazione eugubina, non esitò a offrire sé stesso pur di salvare gli ostaggi e
la città. Ebbe un rifiuto sdegnoso.
All’alba del 22
giugno fu eseguita la rappresaglia.
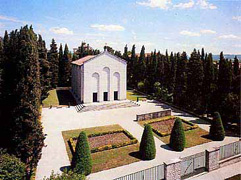 I quaranta designati, dall’edificio scolastico delle Scuole elementari di via
Perugina, dove erano stati tenuti in ostaggio, furono condotti in un luogo poco
distante, dove poi è stato costruito il Mausoleo e in una fossa, fatta scavare
da altri ostaggi poco prima a ridosso del muro che ancora conserva i segni delle
pallottole, legati come bestie da macello affinché non potessero fuggire, furono
uccisi con scariche di mitra, poi finiti a colpi di pistola e ricoperti appena
con qualche manciata di terra.
I quaranta designati, dall’edificio scolastico delle Scuole elementari di via
Perugina, dove erano stati tenuti in ostaggio, furono condotti in un luogo poco
distante, dove poi è stato costruito il Mausoleo e in una fossa, fatta scavare
da altri ostaggi poco prima a ridosso del muro che ancora conserva i segni delle
pallottole, legati come bestie da macello affinché non potessero fuggire, furono
uccisi con scariche di mitra, poi finiti a colpi di pistola e ricoperti appena
con qualche manciata di terra.
 Tra le quaranta vittime ci furono due donne (madre e figlia), due non nativi del
territorio eugubino (uno, un contabile di Gualdo Tadino; l’altro, un
vicebrigadiere dei carabinieri, nativo di Mirto, in Sicilia); ci furono giovani
e meno giovani, studenti, operai, artigiani, contadini, un professionista,
alcuni con la responsabilità di famiglie numerose.
Tra le quaranta vittime ci furono due donne (madre e figlia), due non nativi del
territorio eugubino (uno, un contabile di Gualdo Tadino; l’altro, un
vicebrigadiere dei carabinieri, nativo di Mirto, in Sicilia); ci furono giovani
e meno giovani, studenti, operai, artigiani, contadini, un professionista,
alcuni con la responsabilità di famiglie numerose.
Ha scritto don Origene Rogari poco tempo dopo la strage: «Un genio
infernale parve avesse scelto di proposito alla strage quaranta innocenti,
quaranta casi tutti pietosissimi […] Una madre e la figlia, un figlio unico di
madre inferma, padri di cinque, di
 dieci
figli, un padre di cinque bambini già orfani della mamma, due fratelli insieme,
un padre e il figlio, onesti lavoratori dei campi e della città, due sordomuti,
che non udirono la loro condanna / che profferir non poterono la loro difesa». dieci
figli, un padre di cinque bambini già orfani della mamma, due fratelli insieme,
un padre e il figlio, onesti lavoratori dei campi e della città, due sordomuti,
che non udirono la loro condanna / che profferir non poterono la loro difesa».
La rappresaglia era stata ordinata dal Generale dr. Johann Karl
Boelsen, allora comandante della 114° Jäger Division, cui apparteneva il
battaglione di reggimento, che aveva subito l’uccisione del tenente medico e il
ferimento del sottotenente.
La strage dei Quaranta Martiri, effettuata il 22 giugno 1944, non
può essere isolata dal contesto di altri episodi dolorosi e tragici, che la
popolazione del territorio subì da parte delle truppe nazifasciste.
Tra le vicende più opprimenti si ricordano: il rastrellamento del
27 marzo 1944, che sui confini del territorio comunale recò un numero alto di
morti e arresti, nonché distruzione di case e di edifici; un secondo
rastrellamento, iniziato il 7 maggio nel Buranese e continuato nei giorni
successivi, con un numero inferiore di morti ma non di atrocità; la presa in
ostaggio di 230 persone (anche vecchi, donne e bambini), che si erano rifugiate
presso il Convento di S. Ubaldo nel luglio 1944, sottoposte a privazioni
indicibili per l’assenza di cibo e di altri generi necessari, e terrorizzate dal
fatto che i bombardamenti annunciati e temuti non avrebbero lasciato scampo.
La strage dei Quaranta Martiri produsse inevitabilmente a Gubbio
polemiche a non finire, lacerazioni, un clima pesante, che riguardò sia i
rapporti tra le forze politiche antifasciste, sia i rapporti tra le famiglie dei
Quaranta e ciò che era espressione del movimento partigiano.
Poiché diffusa era la convinzione dell’inopportunità delle due
iniziative partigiane (sia la discesa dal monte per liberare la città sia
l’attacco ai due ufficiali tedeschi presso il caffè cittadino), di conseguenza
si attribuiva al movimento partigiano locale la responsabilità di aver provocato
la rappresaglia tedesca.
Si chiamavano in causa sia gli esecutori materiali della sparatoria
al caffè (Belardi, Ferretti, Paoletti, sfiorando anche Capannelli, del quale
forse non si aveva una spiegazione esauriente di quel che fece); sia il comando
della Gap (Amelio Gambini); sia il comando del gruppo di partigiani che doveva
liberare Gubbio (Bruno Enei, nonché Stelio Pierangeli, il quale aveva impartito
l’ordine di discesa); sia i vertici dell’antifascismo locale (avvocati
Salciarini e Rossi).
Una responsabilità tutta particolare veniva attribuita a Ladislao
Rossi, ritenuto il delatore che avrebbe rivelato al comando tedesco che
l’uccisione dell’ufficiale medico era stata opera di elementi della resistenza
locale.
Queste congetture danno il quadro tormentato delle fratture
che si erano andate consumando nella comunità eugubina.
Di fronte alle accuse, alle insinuazioni, che coinvolgevano
molti, ognuno di questi ha cercato di sgombrare il terreno dalle accuse che lo
riguardavano, riversando le responsabilità su altri, con un rimpallarsi a catena
di responsabilità e polemiche a livello cittadino, senza riuscire a far luce
sulla vicenda.
Anche il tentativo, effettuato sullo scorcio del 1944, di
coinvolgere questura, prefettura, comando militare provinciale in una indagine
per accertare eventuali responsabilità e per iniziare un procedimento penale non
sortì alcun effetto; l’allora questore Guerrizio giunse alla conclusione che
nessuna responsabilità, in ordine alla successiva rappresaglia, potesse essere
addebitata sia ai componenti della pattuglia Gap.
Ben presto a livello provinciale si lasciò perdere tutto.»
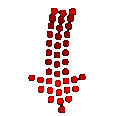
Ci
permettiamo di richiamare alla memoria anche
i fatti bellici di quel
1944, in Italia. |
Il 1944 fu l'anno
della "guerra a Gubbio".
Infatti la nostra città finì per trovarsi al "fronte"
in mezzo gli opposti schieramenti. Gli Alleati,
dopo lo
sbarco in Sicilia
(10 luglio 1943) avevano iniziato la loro risalita lungo la
penisola italiana e avevano condotto una lunga e accanita battaglia
per occupare il settore di
Cassino
la cui conquista (18 maggio 1944) permise alle divisioni
britanniche e statunitensi di continuare l'avanzata verso il nord
unendosi, il 25 maggio, presso Littoria con le truppe sbarcate ad
Anzio il 22 gennaio 1944. Insieme continuarono l'avanzata verso
Roma,
che cadde nelle loro mani il 4 giugno 1944, due giorni prima
del grande sbarco nel nord dell'Europa, in Normandia (6 giugno). La
loro avanzata proseguì poi in direzione di Livorno e Firenze, ma i
Tedeschi costituirono una prima linea di sbarramento (Linea del
Trasimeno) e contestualmente una nuova e robusta linea di difesa
più a nord, la cosiddetta linea gotica, posta attraverso
l'Appennino tosco-emiliano.
|
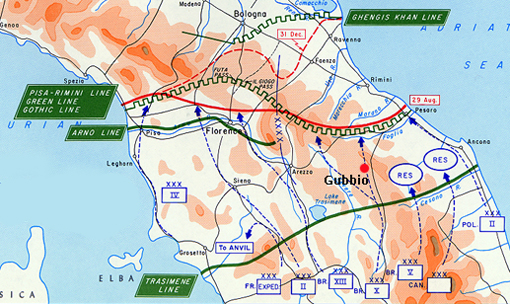 |
L' 11 giugno 1944, superati il lago
di Bolsena ed i monti Sabini, il fronte sul territorio italiano
correva approssimativamente lungo la zona Talamone, Orbetello,
Mandano, Sorano ed Orvieto, per poi scendere, nella valle del Tevere
e del Nera, tra Narni e Terni, fino a sud di Rieti e di Cittaducale.
Il 20 giugno 1944 il X Corpo d'armata britannico occupava
Perugia
senza difficoltà; incontrava invece alcuni ostacoli già sulle
colline che si trovano a nord del nostro capoluogo di Regione. Quei
primi ostacoli dimostravano che "La fase di inseguimento delle
truppe di Kesselring in ritirata era terminata. La linea tedesca era
stata adesso ristabilita. Kesselring aveva ripreso il controllo
delle sue formazioni ed era più che mai deciso a ripetere i successi
difensivi dell'anno precedente. Gli Alleati avrebbero dovuto pagare
in uomini e soprattutto, in tempo, per ogni chilometro della loro
avanzata dal Trasimeno alla linea Gotica" ( W. Jackson).
Il 30 giugno 1944 si era conclusa la
“Battaglia del Trasimeno”,
che aveva visto scontrarsi lungo la “Trasimene Line” la X Armata
Tedesca e l’VIII Armata Inglese. La “Trasimene line”, o “Albert line”
come la indicavano i tedeschi, era una linea difensiva realizzata
dai tedeschi che partiva da Castiglion della Pescaia sul Tirreno per
raggiungere l’Adriatico poco a sud di Ancona.
Dopo giorni di combattimenti con alterne vicende, le forze
alleate riuscivano finalmente ad entrare in possesso di
Arezzo (16
luglio 1944) e dintorni.
Siena era già conquistata (3 luglio 1944). Sul
fronte adriatico Partigiani e militari italiani avevano liberato
Macerata il 30
giugno, e successivamente le truppe alleate raggiungevano la
zona di Ancona ed
iniziava la battaglia per la città, terminata il 18 luglio
con la sua conquista. Lo stesso giorno sulla costa tirrenica, si
verificava un cedimento del fronte tedesco e gli alleati
raggiungevano l'Arno ad est di Pisa, mentre il giorno successivo (19
luglio) entravano in
Livorno.
Pisa per la liberazione dovrà attendere il 2 settembre,
mentre Firenze
sarà liberata l'11 agosto.
Gubbio fu liberata
il 25 luglio 1944
e fino quel giorno fu duramente bombardata dalle artiglierie
tedesche che, dai monti circostanti, battevano la vallata per
contrastare e rallentare l'avanzata delle truppe di liberazione.
Da questo quadro storico, seppure scarno e necessariamente
schematico, si può capire come il territorio del nostro Comune
insieme a quello dei comuni limitrofi (Umbertide, Pietralunga,
Cantiano, Scheggia, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico e Gualdo
Tadino) venne a trovarsi in una fascia geografica che vide,
soprattutto nel periodo marzo-luglio 1944, un progressivo
intensificarsi di operazioni e scontri bellici tra gli opposti
schieramenti, con l'aggiunta delle forze partigiane.
Purtroppo in mezzo a tante armi c'erano anche tanti civili inermi
che spesso sono stati oggetto e vittime di ingiustificate violenze e
di crudeli esecuzioni.
 Per quanto riguarda il Comune di Gubbio, oltre alla
ricordata crudelissima esecuzione dei
"40 Martiri" del 22 giugno 1944,
occorre ascrivere alla storia anche la morte di tanti altri civili
innocenti, come le nove vittime del bombardamento del 13 giugno a
Branca, le due di S.Angelo dopo Serra, le tre di Villamagna, le tre
di Padule e di S. Martino che recentemente sono state riportate alla
memoria da
Gianluca Sannipoli,
e poi molti altri casi singoli. Per quanto riguarda il Comune di Gubbio, oltre alla
ricordata crudelissima esecuzione dei
"40 Martiri" del 22 giugno 1944,
occorre ascrivere alla storia anche la morte di tanti altri civili
innocenti, come le nove vittime del bombardamento del 13 giugno a
Branca, le due di S.Angelo dopo Serra, le tre di Villamagna, le tre
di Padule e di S. Martino che recentemente sono state riportate alla
memoria da
Gianluca Sannipoli,
e poi molti altri casi singoli.
Oggi purtroppo dobbiamo affermare che non esiste un elenco
preciso e definitivo, riteniamo infatti che l'elenco contenuto
nella
delibera n° 312
adottata dalla Giunta Municipale di Gubbio in data 13 aprile 1954 (
ricordata in un recente lavoro di Don
Ubaldo Braccini &
Fabrizio Cece) sia poco
attendibile in quanto accomuna civili non armati "morti in seguito a
rastrellamento" e "morti in combattimento". L'elenco inoltre è anche
alquanto incompleto giacché alcuni morti non vi figurano
affatto. Per esempio non vi figura Ubaldo Palazzari, figlio di
"Rigo de Ragnetto", 18 anni, morto a Fontanelle il 4 luglio
1944, colpito da una scheggia di bomba mentre si trovava davanti la
sua casa colonica.
Vorremmo ritornare, con discrezione, a sollecitare nuovamente la
stesura di un elenco definitivo, per poter restituire alla
memoria anche i nomi di altri "morti civili non combattenti" che
trovarono la morte nel Comune di Gubbio a seguito dei fatti storici
sopra ricordati, nel 1944.
Il
Consiglio Comunale di Gubbio
ha pienamente recepito tale richiesta tant'è che, nel gennaio 2011,
ha approvato all'unanimità' un
ordine del giorno
(a firma dell'allora Presidente del Consiglio Antonella Stocchi) tendente
ad
«incaricare
studiosi/ricercatori per la stesura di un elenco definitivo, per
restituire alla memoria i nomi dei civili che trovarono la morte nel
nostro comune; individuare, in collaborazione con gli enti e le
associazioni interessate, un luogo ove sistemare una lapide o altro
elemento commemorativo riportante i nomi di tutte queste vittime
innocenti della guerra».
Vogliamo sperare che il tutto non cada nel dimenticatoio, anzi
auspichiamo che il nuovo Consiglio Comunale e il nuovo Sindaco,
Prof. Filippo Stirati,
voglia dar seguito a tali decisioni tendenti a realizzare una
degna sistemazione ad una lapide o cippo riportante i nomi di
tutte quelle vittime della guerra, innocenti e dimenticate,
morte a causa della guerra, pur non essendo in guerra.
Pubblichiamo un elenco, pur
incompleto e sicuramente perfettibile.
 |