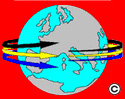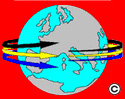|
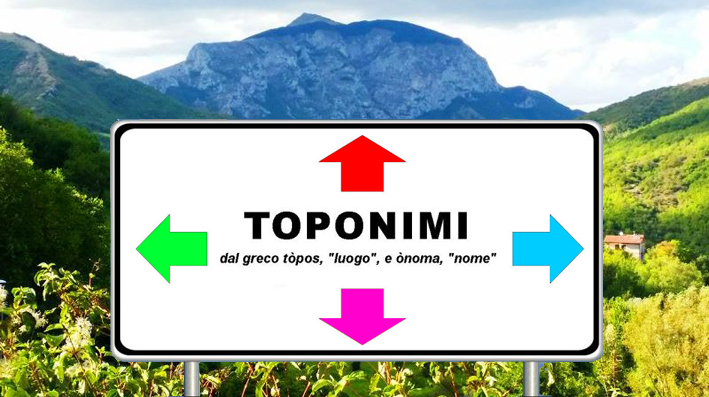 |
|
La parola “Toponimo”
deriva dal greco antico e sta a significare
“Nome del luogo”. |
Nella
caratteristica cornice del “Poggetto” di
Scheggia, davanti ad un pubblico
appassionato e partecipe, si è tenuta, nella serata di lunedì 11 agosto, una
conferenza degli studiosi
Luca Baldelli ed
Euro Puletti dal titolo:
|
«Origine del toponimo
“Scheggia” e riflessione sui vari toponimi ed insediamenti contadini». |
|
 |
Un tributo alla storia locale e popolare che non è certamente
storia di “serie b”, ma storia con la “S” maiuscola, quella dei nostri avi che,
con sacrificio e costanza, ci hanno trasmesso un patrimonio di usi, costumi,
tradizioni e saperi che troppo spesso il mondo moderno tende a dimenticare se
non a rinnegare, preso dai miraggi di un “progresso” le cui crepe si mostrano
sempre più evidenti.
Nelle origini dei nomi di monti, poderi, ville, insediamenti
vari, vi è un tesoro di sapienza e vi sono radici antiche, che han visto
incrociarsi popoli i più vari, dai Romani ai Longobardi, dagli Umbri agli
Illiri, dai Celti ad altri popoli paleo - balcanici, ancora poco studiati, ma le
tracce dei quali emergono sempre più prepotentemente.
Scheggia, con il suo vasto territorio che procede dai confini con
Gubbio e Costacciaro a quelli con Cantiano e Sassoferrato, e Gubbio, con i suoi
525 kmq di estensione (quasi tre volte il territorio di Milano e cinque volte
quello di Firenze), vedono la presenza di toponimi, che rimandano a leggende,
personaggi, prassi agro – pastorali, retaggi religioso – cultuali tenacemente
resistenti all’incedere del tempo e nei quali, spesso, vi è l’invocazione del
Genius loci, lo spirito arcano, eppur sempre presente, che anima i luoghi
stessi.
“Scheggia”, anticamente stazione di posta
con il nome latino di “Ad Ensem”, ha la sua più che probabile origine –
secondo le ricerche autorevolmente condotte dallo studioso Puletti – nel verbo
germanico antico “skleizan”, ossia distruggere, per evidenziare la
distruzione che doveva aver interessato, anticamente, questo centro e che si
ritrova in suggestive leggende come quella del gigante Sanìa, il cui nome
corrisponde a quello dell’antica, mitica Città che ha dato il nome poi, con
modifiche linguistiche, al toponimo Val de Sarnìa.
|
 |
Un identico crogiolo di ancestrali vicende, tra storia reale
e tramandata, lo si ritrova nei toponimi del territorio di Gubbio e Scheggia
che lo studioso Luca Baldelli ha messo in evidenza:
“Brunamonte” di Villamagna, ad esempio, da far
plausibilmente risalire al condottiero e signore eugubino Brunamonte della
Serra, condottiero ghibellino del ‘300, sconfitto dai Montefeltro, due volte
Podestà di Siena;
“Giuccola” (toponimo situato presso tra S.
Andrea del Calcinaro e Costacciaro), che evidenzierebbe la possibile presenza di
santuari o luoghi di culto pagani dedicati a Giove (originando dal verbo colere,
ovvero venerare, con l’aggiunta del nome di Giove);
“Centopanetti” (podere Bracciolo di S. Andrea
del Calcinaro, secondo la toponomastica ufficiale), il quale trarrebbe origine,
vista la presenza della vicina Chiesa di San Sebastiano, dall’usanza di
distribuire ai più poveri il Pane di San Sebastiano, usanza ben viva un tempo ed
oggi circoscritta a pochi luoghi a noi limitrofi (fra i quali una Parrocchia di
Città di Castello).
Alla presenza di pascoli, secondo un’ipotesi non
peregrina, si deve far risalire il toponimo, al confine fra Scheggia e Cantiano,
“Botano” (in greco prato è Botanè), che si incontra anticamente anche a
Gubbio, con la zona di Santa Margherita di Burano chiamata, nelle carte di un
tempo, Botano o Santa Margherita del Botano.
Proseguendo nella rassegna, Puletti e Baldelli hanno
mostrato la probabile origine comune dei toponimi “Balza del Metolone”
(sotto al Monastero di San Girolamo a Monte Cucco, nei pressi del Monte Le
Gronde) e “Metolella” (presso la Serra di Burano), toponimi
legati, con ogni evidenza, al ruolo di confine dei medesimi (meta in latino,
tuder in umbro, tular in etrusco). Ipotesi suffragate da riscontri diretti in
molti casi, in altri contraddistinte, in mancanza di documenti certi, che forse
mai verranno alla luce, da elevato livello di plausibilità, considerati i
raffronti e le somiglianze con altri toponimi similari presenti in altre parti
d’Italia interessate dalle medesime vicende migratorie e di incontro – scontro
fra popoli e genti diverse.
In premessa, ed ancor più dopo l’entusiastica accoglienza da parte
del pubblico, gli studiosi hanno annunciato l’intenzione di trasformare le loro
relazioni in un’opera articolata e dettagliata. La serata ha visto anche un
piccolo intermezzo musicale – recitativo da parte dei relatori.
|
 |
|